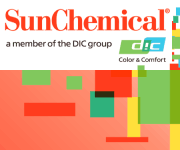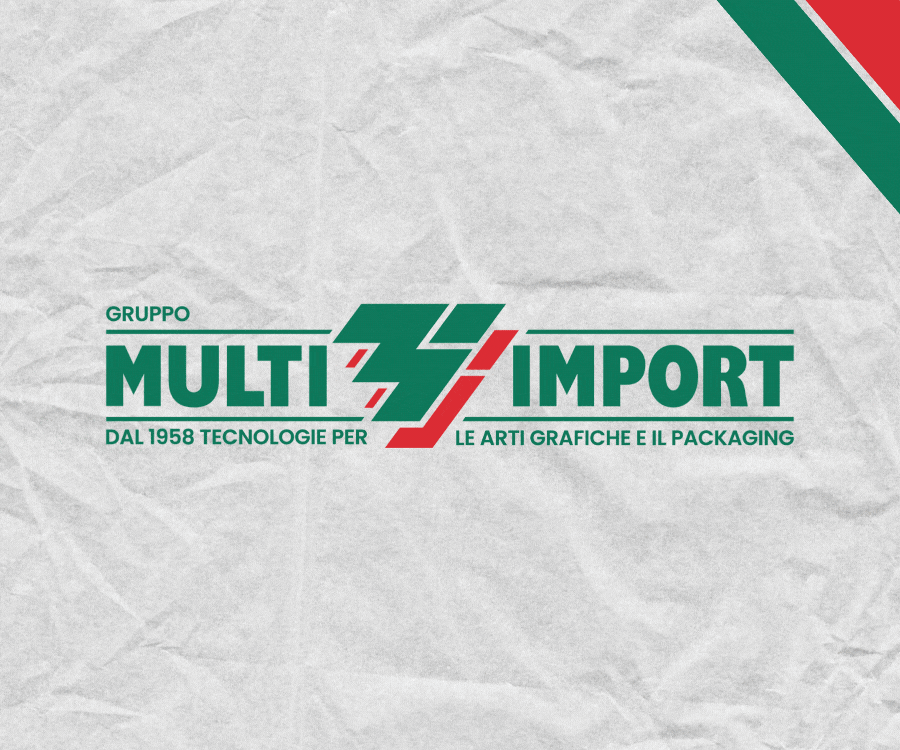Il mercato ballerino delle tazze di caffè - quarta parte

Lo speciale dedicato al mercato del caffè si chiude con i dati relativi ai consumi di questa bevanda tanto amata
Consumi
Nel 2009, sulla base degli ultimi dati disponibili, l’UE25 ha importato 38,5 milioni di sacchi di caffè. La Germania, con 8,9 milioni di sacchi, è il principale importatore europeo, seguita da Italia (5,8 milioni di sacchi), Francia (5,6 milioni di sacchi), Spagna (3,3 milioni di sacchi) e Regno Unito (3,2 milioni di sacchi).
In termini di consumi annui, invece, al primo posto si colloca il Lussemburgo (13,9 kg pro-capite), seguito da Finlandia (12 kg) e Danimarca (8 kg). L’Italia con 5,9 kg pro-capite si colloca (insieme alla Slovenia) al 7° posto della classifica europea che è chiusa dall’Irlanda (1,8 kg) e dalla Polonia (1,5 kg); tali differenze sono spiegabili sia in termini di preferenze (ad esempio il basso consumo del Regno Unito è dovuto alla maggiore diffusione del tè) sia in termini di modalità di consumo (il caffè espresso utilizza una quantità inferiore di caffè rispetto ad altre forme di consumo).
Il caffè è consumato prevalentemente nei paesi sviluppati dove, già da diversi anni, si registra una certa maturità nei consumi (si pensi, ad esempio, che la penetrazione del prodotto presso le famiglie italiane è superiore al 90%), nonostante la crescita in alcuni nuovi mercati, come quelli dell’Est Europa. Tra i paesi produttori, solo il Brasile e l’Etiopia registrano percentuali consistenti di consumi interni.
Se a metà degli anni Novanta il calo dei consumi poteva essere considerato una conseguenza pressoché diretta del prezzo elevato, oggi tendenze più salutiste e i costumi sociali recenti hanno reso il mercato delle bevande fortemente competitivo. I consumi calano fra la popolazione anziana, preoccupata per gli effetti collaterali di una bevanda con conseguenze dirette sul sistema nervoso e fra i giovani che, pur apprezzando il caffè, ne fanno un uso saltuario e sembrano più sensibili ai “soft drinks”. Si tratta di ragioni sanitarie e d’immagine che spiegano sia gli investimenti compiuti dalle associazioni di caffè in campagne d’informazione volte a correggere l’immagine negativa della bevanda sotto il profilo della salute, che le ingenti spese pubblicitarie delle multinazionali del caffè per imporre i loro brand.
Il mantenimento delle quote di mercato, in questa fase, passa attraverso la ricerca di prodotti innovativi come le bevande al sapore di caffè, i caffè di alta qualità da produzione biologica o da produttori certificati Fair Trade e la diversificazione dei canali distributivi come la distribuzione automatica e le macchinette per l’espresso fatto in casa (si pensi alle macchine per caffè espresso ‘A Modo Mio’ della Lavazza o ‘Nespresso’ della Nestlè).
Nel corso dell’ultimo decennio, inoltre, è cambiato anche il modo di consumare caffè nei paesi occidentali: i pionieri di un modo diverso di bere caffè sono stati i locali specializzati dove si può scegliere tra un espresso, un cappuccino, un caffè marocchino o un "caffè americano". Secondo stime recenti, i coffee bar stile Starbuks e Costa si ripartiscono il 40% del valore del mercato americano delle vendite di caffè.
La nascita di nuovi prodotti nella categoria dei “soft drinks” al caffè testimonia che i margini degli stessi sono elevati e compensano ampiamente le perdite di quote nel mercato tradizionale. Su questo punta l’attività di Nestlè con il marchio Nescafè, posizionato su un target giovane desideroso di novità anche nei drink caldi.
I consumi in Italia
In Italia, diversamente dagli altri paesi europei, resiste la tradizione dell'espresso fatto con la macchina o con la moka, dal gusto intenso e dalla classica funzione tonificante. Il consumo di caffè, infatti, continua ad essere associato ad un concetto di tradizione e quotidianità, con una frequenza di consumo più alta nella fascia degli adulti e nei nuclei familiari più numerosi. Secondo alcune indagini recenti, circa il 78% di coloro che bevono regolarmente caffè consuma in media una tazzina al giorno e il maggior consumo si ha nelle prime ore della mattina e subito dopo pranzo. Oltre il 70% dei consumi avviene in famiglia, per cui il comparto della GDO è quello in cui si concentra la competizione fra le maggiori aziende del settore e non solo. Anche le marche commerciali, negli ultimi anni, e seguendo gli orientamenti strategici proposti dai grandi retailer europei (Tesco, Sainsbury’s, Carrefour, ecc.), stanno introducendo nuove linee di caffè con sempre maggiore attenzione verso le miscele prodotte con caffè biologico o provenienti da produttori riconosciuti da un marchio di certificazione del commercio equo e solidale.
Il mercato del caffè italiano è caratterizzato da un’elevata concorrenza, nel quale la leva del prezzo e la leva promozionale vengono utilizzati dagli attori della distribuzione alimentare al fine di mantenere il vantaggio competitivo. Il comparto, oltre ad evidenziare una saturazione della domanda conseguente alla stabilità dei consumi, risulta fortemente concentrato: nel canale della grande distribuzione organizzata primi tre produttori (Lavazza, Kjs/Kraft, Cafè do Brasil-Kimbo) coprono congiuntamente oltre il 70% delle vendite complessive sia in valore che in volume. Attraverso i canali della GDO vengono commercializzati i due terzi dei volumi complessivi di caffè e per le fasce medie di reddito la scelta dei consumatori viene fortemente influenzata dalle politiche di prezzo praticate sul punto vendita dai torrefattori o dalle imprese distributrici.
In questo contesto, le private label si attestano - nel segmento moka - su una quota che sfiora il 4% in volume, limitata in termini percentuali ma significativa sul piano delle dimensioni assolute delle vendite di prodotti a marchio del distributore.
Il posizionamento di prezzo dei competitor vede un grande affollamento nelle fasce intermedie, ma il ventaglio dei prezzi oggi presenti sugli scaffali della GDO è amplissimo: si va, infatti, dai primi prezzi fino ad arrivare ad una marca come Illy che da sempre si posiziona su un livello di prezzo elevato rispetto alle altre marche nazionali. Da rilevare, come altro esempio particolare, la focalizzazione esclusiva del marchio Hag nel segmento del decaffeinato, di cui domina le vendite, un segmento che ad oggi pesa intorno al 5% in volume sul totale commercializzato.
Il quadro competitivo, infine, va letto anche rilevando la forte presenza di torrefattori locali (oltre 700) i cui marchi, in particolar modo al Sud, raggiungono talvolta quote di mercato notevoli poggiando la loro forza su una tradizione locale e su prodotti di qualità che garantiscono la fedeltà della clientela.
[nggallery id=18]